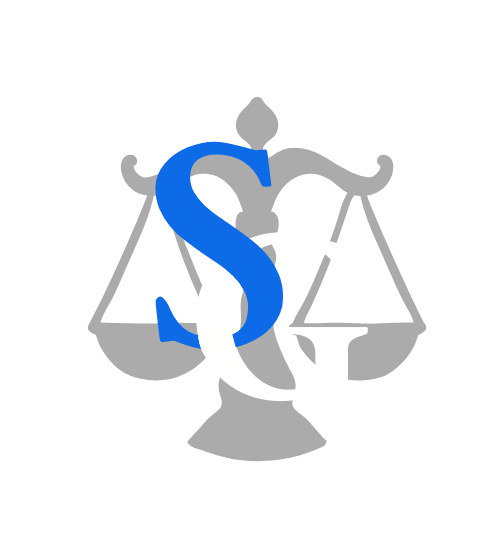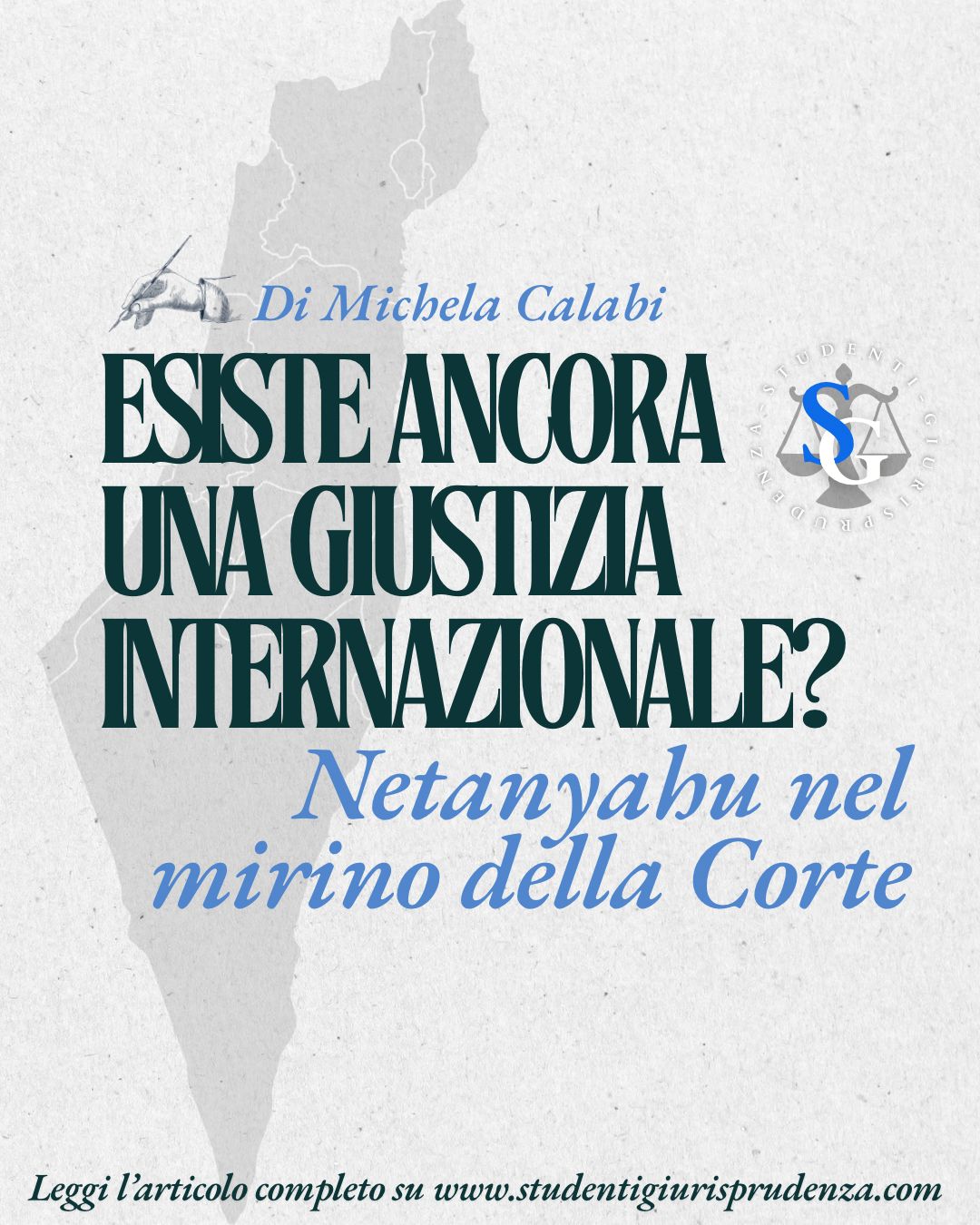È il 20 maggio 2024. Il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, chiede l’emissione di mandati d’arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu (premier israeliano), Yoav Gallant (ex ministro della difesa israeliano) e Mohammed Deif (braccio armato di Hamas) per crimini di guerra e crimini contro l’umanità consumati all’interno della Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023.
Sei mesi dopo, il 21 novembre, la Corte de L’Aia decide: Netanyahu e Gallant sono dichiarati responsabili di crimini internazionali. La loro strategia bellica si è caratterizzata per la privazione di cibo, acqua, elettricità e medicine nella Striscia di Gaza, provocando così la morte di civili e violando i diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita e alla salute. Crimina iuris gentium.
La decisione della Corte rianima il dibattito pubblico sul conflitto che continua a flagellare, inarrestabilmente, il Medio Oriente.
La Corte penale internazionale è un tribunale per crimini internazionali con sede a L’Aia, istituito nel 1998 con un trattato, lo Statuto di Roma, di cui sono firmatari 123 Paesi; esercita la propria giurisdizione sulla responsabilità penale degli individui (non degli Stati nazionali) ed ha competenza in relazione ai più gravi crimini internazionali, in particolare: genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
La decisione in questione rappresenta un unicum nella storia del tribunale, trattandosi della prima volta che viene emanato un mandato d’arresto contro leader politici alleati dei paesi occidentali. Sin dalla sua creazione, infatti, si era limitato a condannare per lo più paesi africani per violazioni dei diritti umani, e questo aveva generato numerose critiche: la Corte fu accusata di operare con un “doppio standard”, sulla base di criteri di giudizio differenti a seconda del paese interessato. Mentre, oggi, il mandato viene emesso nei confronti di leader di governo di un paese fino ad ora sostenuto in maniera trasversale da tutto l’Occidente, nel suo “diritto di difendersi da attacchi terroristici”.
Eppure, non fanno parte dello Statuto di Roma le tre maggiori superpotenze mondiali, Russia, Stati Uniti e Cina, mentre Israele ha firmato ma non ratificato la Convenzione.
Ed è proprio questo il tasto dolente della questione: i paesi firmatari dello statuto hanno l’obbligo per tabulas di dare esecuzione alle decisioni della CPI e quindi, nel caso di specie, di arrestare i soggetti nei cui confronti sia stato emesso il mandato che si trovino nel territorio nazionale, affinché possano essere processati dinanzi alla Corte.
Ma il tribunale non possiede alcun mezzo di coercizione per spingere i paesi membri – e, a maggior ragione, i paesi non firmatari dello Statuto, che non riconoscono la sua giurisdizione – ad eseguire le decisioni, non disponendo di una propria forza di polizia o di altri organismi esecutivi, ed essendo rimessa l’esecuzione dell’arresto, in definitiva, ai singoli Stati.
Questo il tema cruciale: è oggi, più che mai, fondamentale rispettare il diritto internazionale, come ci ricorda la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese: “Il sistema scricchiola. O lo si rafforza, o ciò che è stato costruito negli ultimi settanta anni a protezione dei diritti umani è destinato a svanire”.
Interessi politici divergenti e limiti strettamente giuridici rendono difficile che i leader di Israele e Hamas vengano arrestati e processati dinanzi alla Corte.
Ciò che preme sottolineare a questo punto è quanto segue: indipendentemente da chi sia il destinatario di un mandato di arresto e dalla forza esecutiva delle decisioni degli organismi internazionali, la funzione giurisdizionale è – e dovrebbe restare – scevra da qualsiasi coinvolgimento con la politica.
Giudici nazionali ed internazionali devono decidere esclusivamente sulla base dei parametri giuridici: questi costituiscono il perimetro ed i confini invalicabili del loro sindacato, non potendo far transitare considerazioni di natura politica nelle proprie valutazioni.