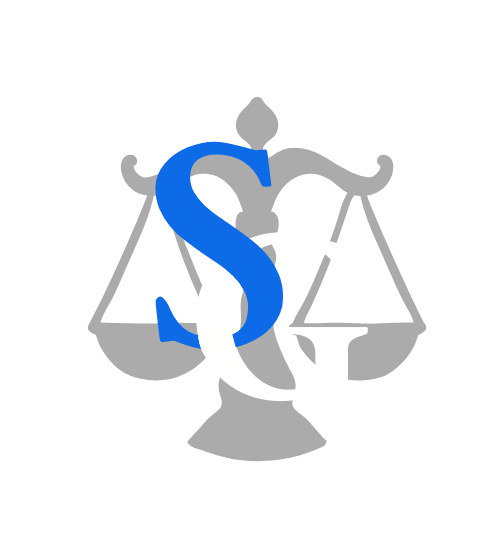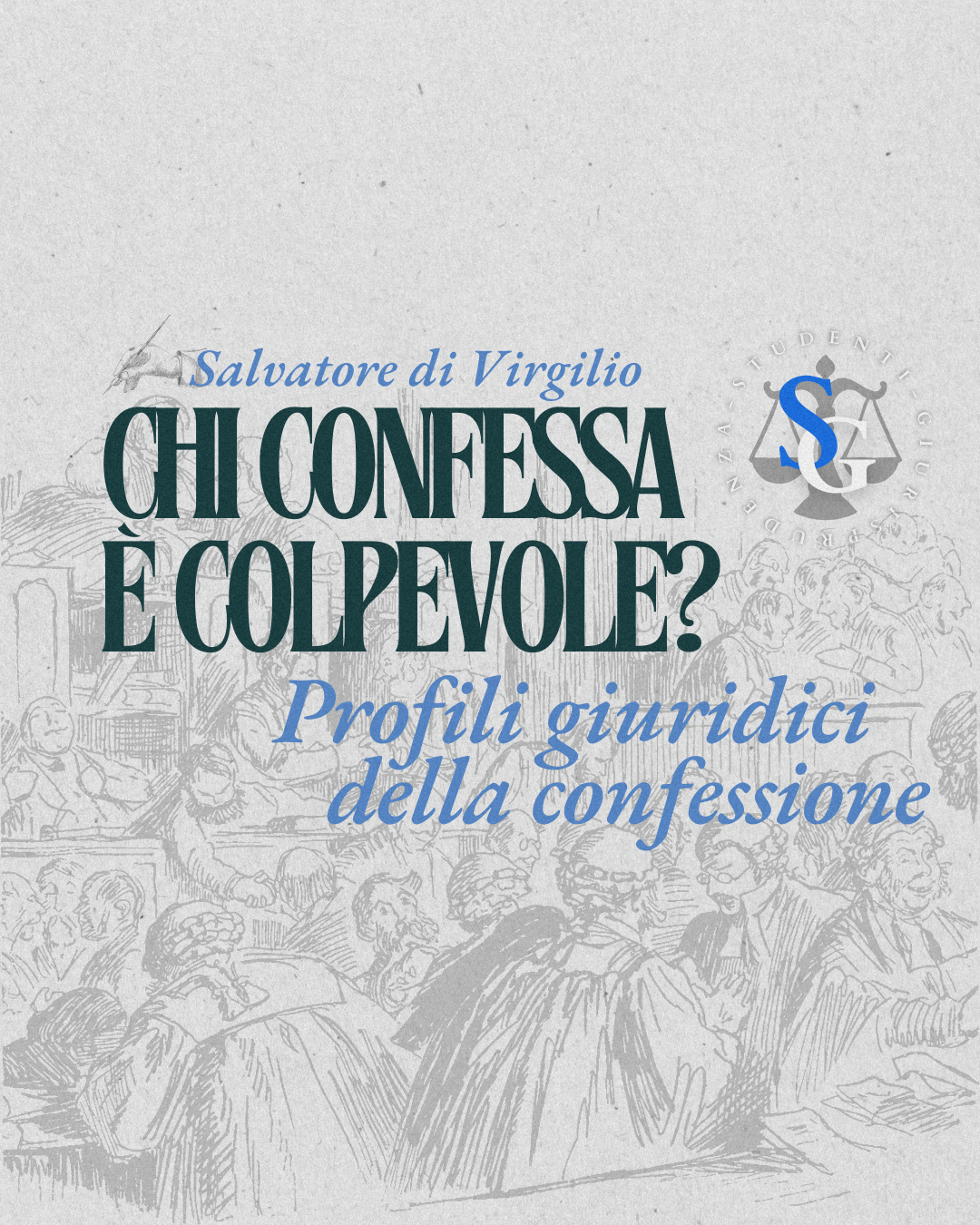I casi nei quali durante un interrogatorio la persona indagata o imputata ammetta di aver commesso un reato, non sono rari. La questione è rilevante tanto da un punto di vista giuridico, quanto sociale. Parlando in termini di buon senso, si potrebbe concludere che chi confessa sia sempre colpevole. Ma il giurista ha qualche cruccio in più, poiché questa relazione, almeno nel nostro ordinamento, non è così lineare. Perché chi confessa non è sempre colpevole? Perché rendere confessioni non veritiere?
Vuoi per depistare le indagini, per ottenere fama o per proteggere un proprio familiare, ci sono stati casi di confessioni non veritiere. Pensiamo al padre che confessa un furto in realtà commesso dal figlio, un gesto sicuramente comprensibile, ma resta una confessione mendace.
Se sfogliamo il Codice di procedura penale, non troviamo una definizione di confessione e salta anche all’occhio che questa non sia nemmeno compresa tra i mezzi di prova, cioè quegli strumenti attraverso i quali la prova è formata dinanzi al giudice che dovrà decidere la causa. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che il Codice, all’art.189, consente l’introduzione di prove non espressamente disciplinate. Vero, ma le prove innominate necessitano di un vaglio preliminare di ammissibilità ad opera del giudice. Ergo, la confessione non sempre ha valore probatorio.
Allora cosa succede se l’indagato confessa in sede di interrogatorio? Quella confessione assurge ad elemento rilevante per le indagini preliminari, potendo essere utile al pubblico ministero per orientare la sua attività investigativa. Ad esempio, chi confessa può indicare l’ubicazione dell’arma del delitto o fornire dettagli specifici sulla dinamica del reato. Tali indicazioni, se corroborate da riscontri oggettivi, possono contribuire alla formazione di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, tale da escludere ulteriori ragionevoli ricostruzioni.
Inoltre, il Codice conferisce l’opportunità al pubblico ministero di accedere ad un rito speciale: il giudizio direttissimo, disciplinato dagli artt. 449 e ss. c.p.p. La richiesta sarà rivolta al giudice del dibattimento, che nulla sa della confessione, e si sostanzia in una modalità di esercizio dell’azione penale. Tale rito consente una semplificazione procedurale, riducendo i tempi e i costi del processo, senza però compromettere le garanzie difensive dell’imputato. Ma, in ogni caso, un giudizio ci sarà e non si tratta di una mera formalità. È un giudizio vero e proprio, che si instaura dinanzi ad un giudice “vergine” della vicenda, che vedrà la prova formarsi dinanzi a sé.
Ma l’imputato può essere costretto a confessare davanti al giudice? Beh, neminem tenetur se detegere, nessuno può essere costretto ad autoaccusarsi. E se confessa spontaneamente? Potrebbe farlo visto che l’imputato può, in ogni stato e grado del procedimento, rendere dichiarazioni spontanee. Ma sarà sempre il giudice a valutare quelle dichiarazioni, ed eventualmente disporre una perizia psichiatrica per verificarne l’attendibilità.
Il giudice terrà conto di tutte le prove che si sono formate davanti a sé, tali da permettergli di ricostruire gli accadimenti della realtà materiale. Solo così saranno garantiti i diritti fondamentali dell’imputato, in primis il diritto alla prova e ad un giusto processo. In conclusione, la confessione non costituisce un mezzo di prova in senso tecnico, ma rappresenta uno strumento di supporto investigativo, consentendo al magistrato inquirente di dirigere le indagini e di rafforzare l’impianto accusatorio.