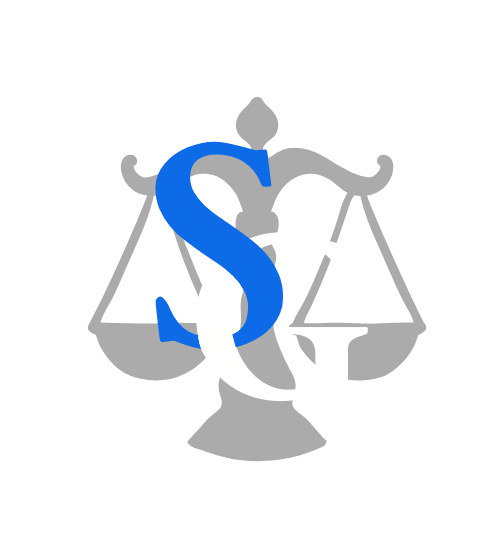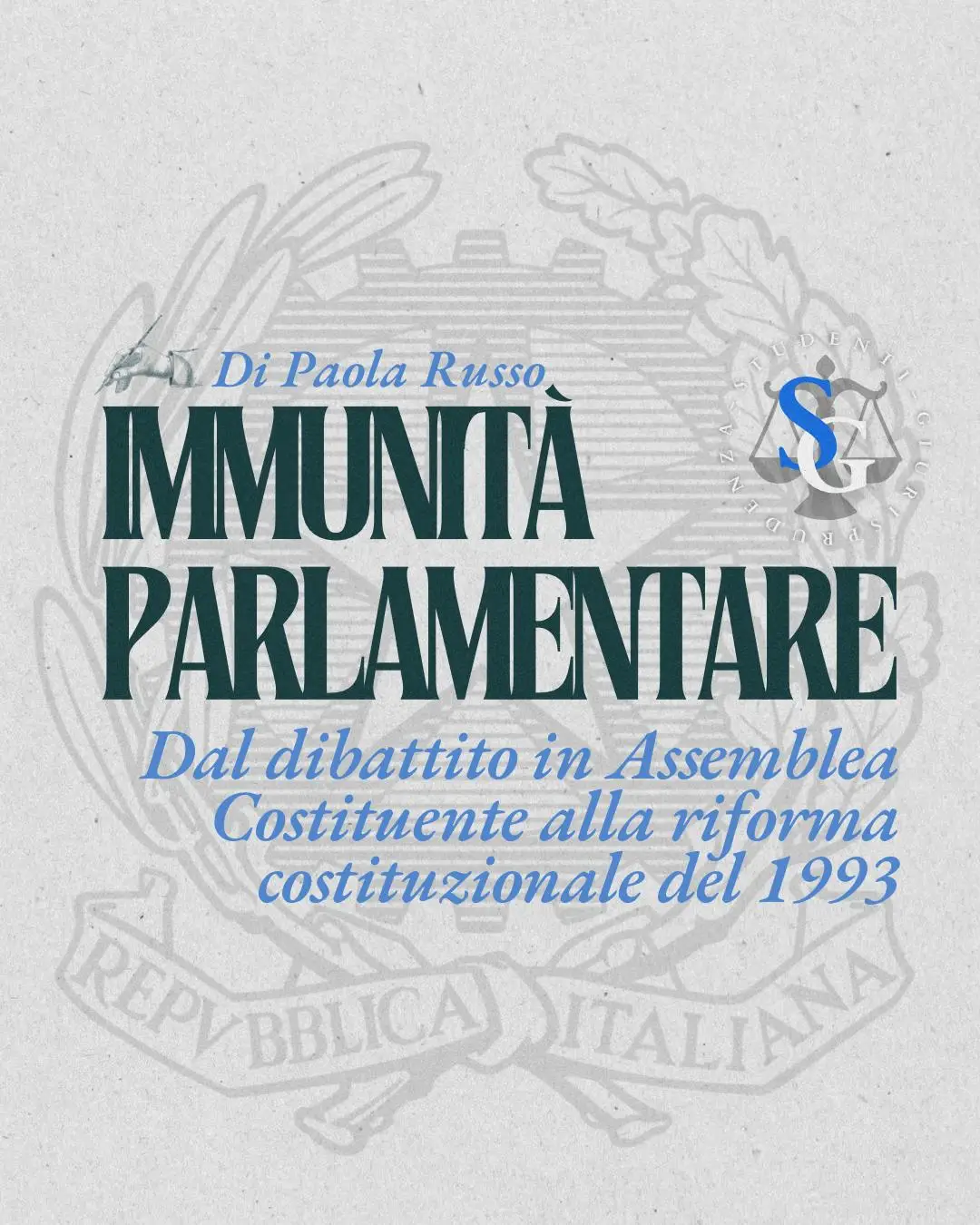Immunità parlamentare. Dal dibattito in Assemblea costituente alla riforma costituzionale del 1993
Sommario: Cenni introduttivi; L’immunità parlamentare nella previsione originaria della Costituzione; La riforma del 1993 e la successiva giurisprudenza costituzionale; Conclusioni
Cenni introduttivi
Nel pieno della XIX legislatura, l’immunità parlamentare ritorna al centro del dibattito politico e istituzionale del nostro Paese. Un istituto che rappresenta un pilastro degli edifici costituzionali del nostro tempo e che anima l’attuale dibattito parlamentare a seguito del disegno di legge della Fondazione Luigi Einaudi: la proposta prevede una modifica dell’art. 68 Cost. al fine di ripristinare l’immunità parlamentare in una chiave meno “restrittiva” e più vicina alla formulazione originaria della disposizione costituzionale, ripristinando la previsione dell’istituto dell’autorizzazione a procedere in caso di sottoposizione del parlamentare a procedimento penale.
L’immunità parlamentare nella previsione originaria della Costituzione
La prima formulazione dell’art. 68 Cost. – proposta dal giurista Costantino Mortati nella seduta del 19 settembre 1946 della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione 1 – prevedeva che i deputati non potessero essere sottoposti a procedimento penale né privati della libertà personale, nemmeno in esecuzione di una sentenza di condanna, senza l’autorizzazione della Camera. In caso di arresto in flagranza di reato, l’autorità procedente era tenuta a darne immediata comunicazione alla Presidenza della Camera, affinché l’Assemblea deliberasse.
A seguito dell’entrata in vigore della Costituzione, furono posti dei problemi applicativi riguardanti la norma costituzionale. Il successivo dibattito si sviluppò lungo due filoni tematici: da un lato, quello della possibile estensione della non perseguibilità alle affermazioni espresse al di fuori delle Camere, riconducibili alle attività politico-istituzionali dei parlamentari; dall’altro, quello della natura giuridica delle prerogative costituzionalmente protette – una vexata quaestio ancora oggi al centro di un vivace dibattito interpretativo, anche in considerazione delle conseguenze pratiche che derivano dal corretto inquadramento dogmatico dell’istituto (alcune: rilevanza dell’errore e risarcimento del danno) 2 .
Negli anni immediatamente precedenti alla riforma costituzionale del 1993, la prassi adottata dalle Camere in merito all’utilizzo della garanzia da parte della maggioranza parlamentare accese un forte dibattito; da alcuni fu rilevata, in particolare, una elevata difficoltà di razionalizzazione dell’istituto a causa dell’assenza di criteri normativi ulteriori.
Il riferimento era innanzitutto alla mancata previsione normativa di un termine per deliberare; a tal proposito, nel 1987 fu proposto un progetto di legge costituzionale 3 volto ad introdurre un meccanismo di silenzio-assenso in virtù del quale, in difetto di una deliberazione nei termini prescritti – centoventi giorni, quindici in caso di sentenza passata in giudicato – l’autorizzazione a procedere si riteneva concessa.
Questo tentativo di limitare le prerogative del Parlamento, però, non vide mai la luce.
La riforma del 1993 e la successiva giurisprudenza costituzionale
La revisione costituzionale dell’art. 68 Cost. si colloca all’interno di un periodo – XI legislatura – caratterizzato da un mutamento politico così profondo da far parlare di Seconda Repubblica.
La legge costituzionale n. 3 del 1993 confermò lo schema previsto dal testo originario dell’art. 68 Cost., fondato su due prerogative – l’insindacabilità (art. 68, primo comma, Cost.) 4 e l’inviolabilità (art. 68, secondo comma, Cost.).
Per quanto concerne il nuovo regime dell’inviolabilità, furono tre gli aspetti più rilevanti: l’eliminazione dell’autorizzazione a procedere per la sottoposizione a “procedimento penale”, quella per l’arresto o il mantenimento in detenzione in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, e, in ultimo, l’introduzione dell’autorizzazione per la sottoposizione dei parlamentari a “intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza”.
La ratio di questa nuova impalcatura è stata evidenziata chiaramente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007: la nuova formulazione dell’art. 68 Cost. sottende ad un bilanciamento necessario tra l’interesse al libero corso della giurisdizione penale e quello (non già dei parlamentari uti singuli, ma) delle assemblee a conservare l’integrità del plenum e la piena autonomia decisionale.
Successivamente alla modifica dell’art. 68, comma 2, Cost., si registrò un nuovo dibattito interpretativo inerente alla corretta individuazione dell’ambito materiale dell’insindacabilità. Le Camere tentarono di bilanciare l’abolizione dell’autorizzazione a procedere estendendo la prerogativa anche agli interventi a mezzo stampa, trasmissioni radiofoniche o televisive, alle occupazioni di sedi stradali e alle interruzioni di
pubblici servizi. A questo orientamento estensivo si è più volte contrapposta la giurisprudenza della
Corte costituzionale, che ha, a più riprese, individuato il limite estremo dell’insindacabilità utilizzando il concetto di “nesso funzionale” tra espressione di opinioni e di voti ed esercizio delle funzioni parlamentari.
La sentenza n. 10 del 2000 ha escluso ogni discrezionalità interpretativa nella valutazione circa la sussistenza della protezione costituzionale: il “nesso funzionale”, secondo la Corte, sussiste qualora concorrano due requisiti: a) un legame di ordine temporale tra l’attività parlamentare e l’attività esterna, tale che quest’ultima assuma una finalità divulgativa della prima; b) una corrispondenza di significato sostanziale tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni 5 .
Conclusioni
I mutamenti dell’art. 68 Cost. hanno determinato un’alterazione dei rapporti tra i poteri dello Stato, comprimendo ulteriormente lo spazio di concordanza tra giudici e parlamentari sviluppato nel primo cinquantennio di storia repubblicana; il dibattito attuale che ne consegue – che non può che esserne contaminato – degrada la funzione di accertamento del processo penale ad un attacco di un potere contro un altro, come due corporazioni in lotta tra di loro.
1 L’assemblea Costituente nominò al suo interno una Commissione per la Costituzione, composta da 75 membri e presieduta da Meuccio Ruini, che si organizzò in tre Sottocommissioni: la prima, sui diritti e doveri dei cittadini; la seconda, sull’organizzazione costituzionale dello Stato, poi divisa in due sezioni (una sul potere esecutivo, l’altra su quello giudiziario); e la terza, sui rapporti economici e social.
2 D. Perrone, Sulla natura giuridica dell’immunità parlamentare: la responsabilità dell’eventuale concorrente del reato, Rivista AIC n°1/2012
3 Disegno di legge costituzionale del Senato della Repubblica n. 507, del 6 ottobre 1987
4 I membri del parlamento “non possono essere chiamati a rispondere delle” (invece che “perseguiti per le”) opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
5 G. Scaccia, Spunti per una ridefinizione del “nesso funzionale” in tema di insindacabilità parlamentare, Rivista AIC n°4/2014