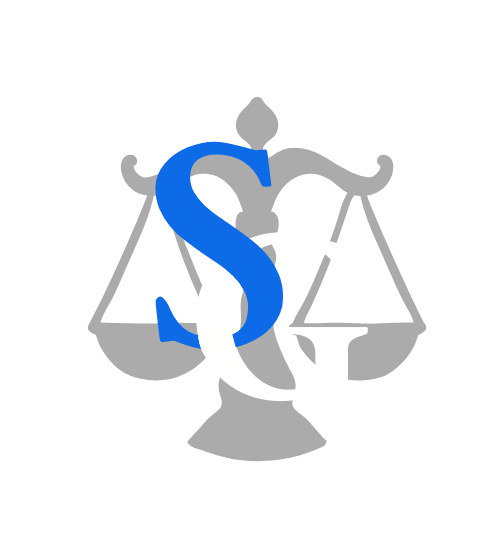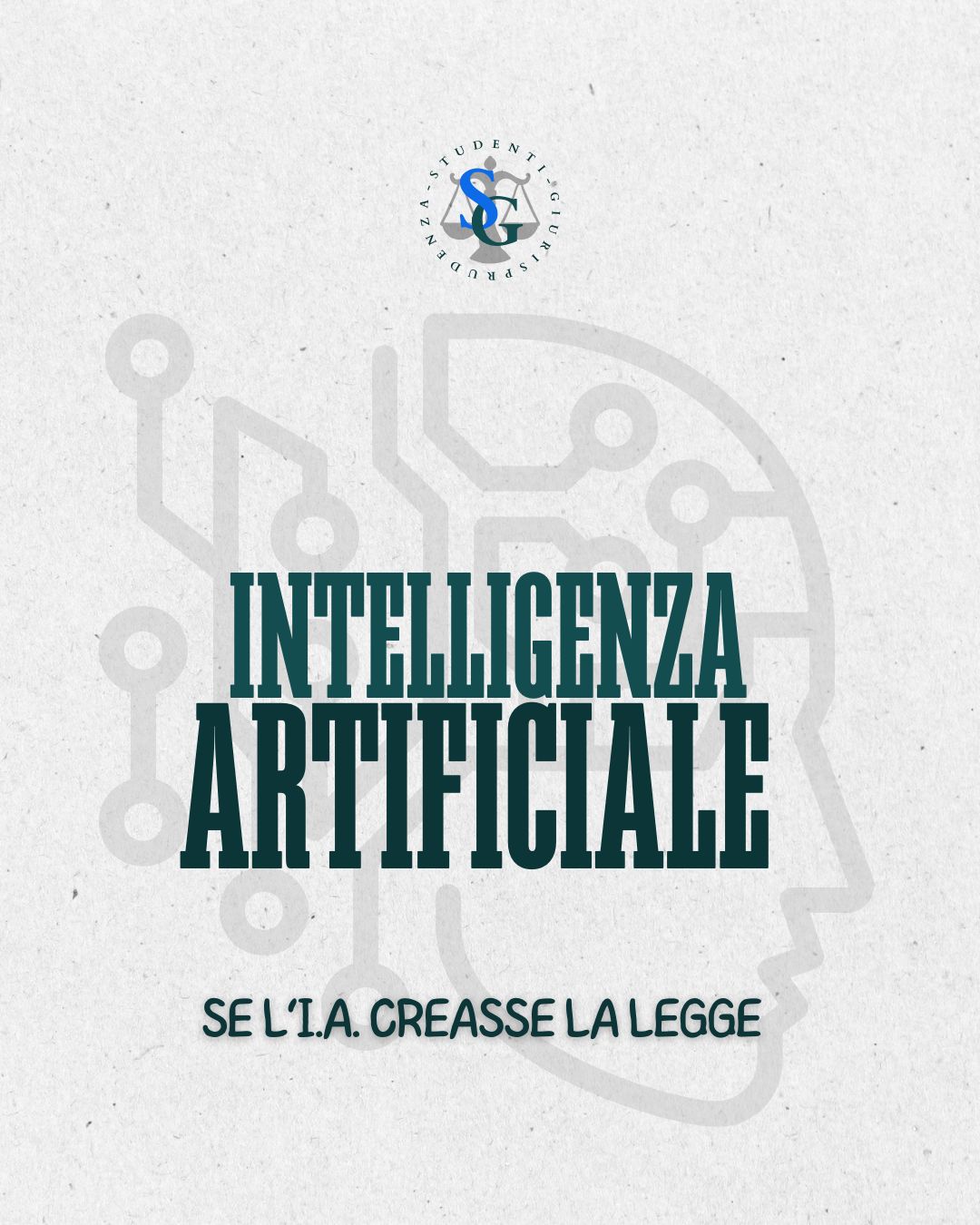SE L’I.A. CREASSE LA LEGGE
Il dibattito sull’intelligenza artificiale è contraddistinto da una rinnovata linfa vitale, complice il rapido sviluppo tecnologico verificatosi negli ultimi decenni.
L’espressione intelligenza artificiale fu coniata nel 1956 dall’informatico statunitense John McCarthy, vincitore del Premio Turing nel 1971 e noto per aver realizzato il linguaggio Lisp.
Iniziò così a germinare l’intento di dar vita ad un sistema informatico che potesse replicare, con un alto grado di fedelta, il modo di ragionare umano ma con un potenziale applicativo esponenzialmente più ampio. In tal modo l’analisi dei numerosissimi dati provenienti dall’ambiente esterno sarebbe stata più agevole. A titolo esemplificativo, infatti, secondo uno studio condotto dal Parlamento europeo il volume dei dati prodotti nel mondo dovrebbe passare dai 33 zettabyte del 2018 ai 175 zettabyte nel 2025, tenuto conto che un zettabyte equivale a mille miliardi di gigabyte. Partendo da simili premesse non stupisce che l’UE mostri un rinnovato interesse per la questione Al, ciò emerge chiaramente da una risoluzione del 2019 sull’uso dell’intelligenza artificiale per facilitare la vita della realtà comunitaria.
L’interesse per le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, tuttavia, attecchisce anche a livello nazionale. Si ipotizza, per esempio, di utilizzare la cd. intelligenza generativa per redigere i testi delle leggi per evitare che in esse abbondino ridondanze, esasperati voli pindarici, in modo da rendere i testi normativi più accessibili alla conoscenza dei cittadini.
Questa prospettiva, però, merita di essere valutata solo nella misura in cui essa non produca una depauperazione dei poteri delle istituzioni, Parlamento in primis, circa lo svolgimento del regolare iter legislativo. Infatti non è costituzionalmente legittimo affidare ai sistemi Al i compiti suddetti senza che vi sia la supervisione di coloro democraticamente eletti dalla comunità di cittadini.