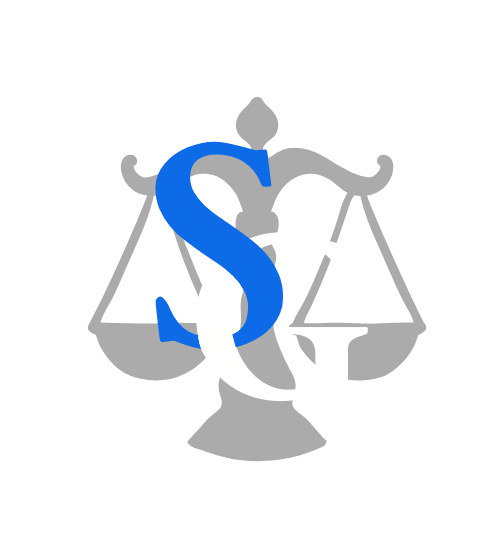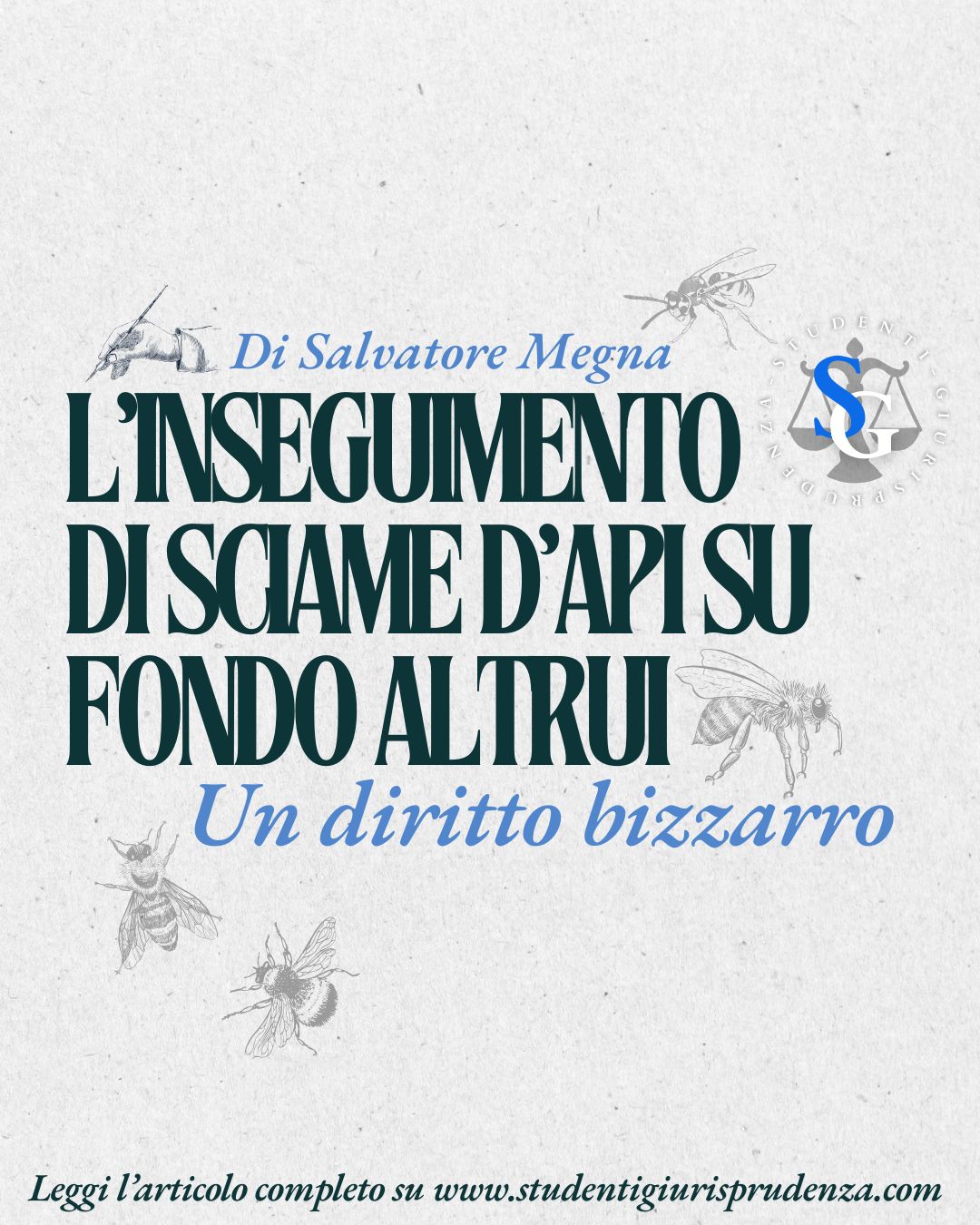Chiunque, aprendo un qualsiasi codice di diritto, per studio, diletto o necessità, si sarà probabilmente imbattuto in una serie di articoli dal contenuto quantomeno enigmatico, per non dire misterioso.
Questo lo si deve sia alla stratificazione del diritto stesso, conseguenza dello scorrere dei secoli, sia alla trasformazione delle categorie sociali e teoriche con le quali osserviamo il mondo.
Talvolta, alcuni di questi articoli ai nostri occhi possono perfino apparire bizzarri.
E’ innegabile che uno di questi sia l’articolo 924 del codice civile italiano, che recita:
“il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita’ per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, puo’ prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.”
Non si può che rimanere confusi leggendo questo, all’apparenza, bizzarro articolo.
Sono sicuro, inoltre, che molti di voi penseranno che questo articolo sia sempre rimasto inapplicato, trattandosi di una vetusta reminiscenza del passato, in particolare del passato di uno stato agricolo, come era l’Italia del tardo Ottocento.
La disposizione in questione affonda le sue radici, infatti, proprio nel diciannovesimo secolo, in particolare nel codice civile italiano del 1865, nell’art. 713. La formulazione di quest’ultimo appariva, nella sostanza, identica a quella dell’attuale articolo 924.
Scavando nei meandri degli archivi giurisprudenziali italiani è possibile rinvenire dei casi in cui si è fatta applicazione di questa disposizione.
A tal proposito, è emblematica una sentenza della Corte di Cassazione, datata 19 febbraio 1932 e riguardante una vicenda, alquanto strampalata, avvenuta in Abruzzo.
La II sez. della Suprema Corte venne chiamata a statuire sulle doglianze di un tale signor Ventresca, il quale aveva convenuto in giudizio il signor Rossi per essere entrato nel proprio giardino, al fine di recuperare uno sciame d’api posatosi sul ramo di un albero.
Il signor Rossi asseriva che tale sciame fosse di sua proprietà ed aveva agito quindi senza aspettare l’intervento della pubblica autorità. Questo modus agendi, a parere del Ventresca, era prova indubitabile che il signor Rossi si trovava nel torto. Ma i giudici erano di diverso avviso. La Cassazione, quindi, rigettava il ricorso del Ventresca, argomentando che fosse evidente come il signor Rossi si stesse muovendo nei limiti della facoltà concessagli dal codice.
Il caso succitato è uno dei pochi esempi in cui possiamo osservare l’applicazione di questo particolare istituto del codice civile.
Dunque, è possibile constatare l’inutilità di questa disposizione, considerando la sua scarsa applicazione?
Ciò non è possibile per una serie di ragioni di carattere sistemico.
In particolare, il diritto concesso al proprietario di inseguire sul fondo altrui gli sciami d’api può essere esteso in via interpretativa a tutti gli animali mansuefatti. Nello specifico questo diritto si inserisce nella categoria, di più ampio respiro, dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario. Trattasi di quelle modalità di acquisto della proprietà che avvengono non tramite atti di autonomia negoziale, che danno vita ad un acquisto a titolo derivativo, bensì tramite semplici fatti, anche naturali (ad esempio la costruzione di un’opera sul mio terreno), ovvero mediante atti giuridici compiuti da un soggetto interessato a divenire titolare di un diritto di proprietà.
Per capire approfonditamente il ruolo dell’art 924 c.c., ci dobbiamo riferire ad uno specifico modo di acquisto della proprietà a titolo originario: l’occupazione.
Per quest’ultima si intende l’impossessamento materiale di una res, la quale non appartiene a nessuno, accompagnato dalla volontà (c.d. animus) di farla propria. La categoria di questi beni è detta “res nullius” e vi 8è una disposizione ad hoc del codice civile, l’art 923:
“Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.”
Appare chiara ora l’importanza dell’articolo 924 c.c., il quale offre una tutela al legittimo proprietario delle api, che le può inseguire per evitare che lo sciame diventi di proprietà di altri, in particolare del proprietario del fondo ove le api sono sciamate.
D’altronde, l’importanza delle api per l’ecosistema doveva essere evidentissima, già in tempi non sospetti.
Il legislatore, tenendo conto della drastica riduzione della popolazione di api in Italia, diminuita del 30% negli ultimi dieci anni, ha emanato una serie di leggi ad hoc, affiancandole alla tutela civilistica analizzata e che, come abbiamo visto, riguarda per lo più la posizione dell’apicoltore.
Mi riferisco, in particolare, alla L.313/2004, con cui si è coniugata la tutela degli apicoltori con quella della specie italiana di ape. Ciò è ben visibile dall’art.1 co.1 della suddetta legge:
“La presente legge riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed e’ finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.”
Non ci resta che augurarci che la crescente attenzione sulla questione porti ad una definitiva inversione del trend di riduzione delle api ed auspico che questo articolo possa, seppur in minima parte, aver contribuito non solo a soddisfare qualche curiosità, ma anche ad aver sensibilizzato sul tema.